Botros 1 - Le teorie sociali
Concetta Federico
Le teorie della società

Oggi più che mai, l’essere umano è costantemente alla ricerca di significato del suo vivere e ad offrirci un’aiuto in questo senso, intervengono le teorie sociali che ci forniscono gli strumenti necessari per comprendere il mondo sociale, ovvero un “universo di mutue risposte regolarizzate, un’area culturale al cui interno attività e problemi comuni e interconnessi sono legati insieme da una rete di comunicazione”. (Strauss 1978).
Osservare la società sotto la lente della teoria sociale ci permette di vedere le cose in modo differente, analizzare come le società possono convivere e come organizzano ed influenzano il nostro agire, come si sono evolute nel corso del tempo. Ciò che qui analizzeremo, sono solo alcune delle teorie sociali che hanno caratterizzato le società fin dal principio, con un’attenzione particolare alla creazione, alle relazioni tra gli essere umani come caratterizzanti le interazioni ed i ruoli che ognuno riesce a ritagliarsi nella società moderna.
Secondo il famoso filosofo politico, Michael Huemer, i criteri per valutare le teorie sociali, devono essere intesi in senso relativo e comparativo, al fine di poter meglio definire se una teoria è peggiore o migliore di un’altra. Di conseguenza, lo standard assunto per valutare una teoria sociale, non deve ambire alla perfezione, in quanto non appartenente al genere umano, ma quantomeno respingere un sistema sociale qualora possiamo individuare una alternativa migliore.
Tuttavia, analizzando vantaggi e svantaggi di un dato sistema, potremmo considerare le pratiche della propria società come le migliori, perché ad esempio, fondanti sul sistema delle consuetudini e dell’identità sociale o per meglio intenderci soffermarci sull’idea comune della propensione dell’individuo allo status quo.
Tale teoria, sostiene che il gruppo sia luogo di nascita dell’identità sociale, dato che l’uomo ha la spontanea tendenza a sentirsi parte di un gruppo, a formarne uno e a favorirlo rispetto agli altri (Henry Tajfel).

Questa teoria si costituisce attraverso 3 fasi:
I processo: categorizzazione, secondo il quale l’individuo tende a determinare delle categorie per indicare la sua appartenenza ad un gruppo, in base a fattori di vario tipo (sesso, età, appartenenza sociale, posizione lavorativa, religione). Durante questo processo, l’individuo trova maggiori somiglianze ed allo stesso tempo evidenzia differenze rispetto agli individui esterni al gruppo;

II processo: identificazione, secondo il quale l’appartenenza ai vari gruppi offrono la base psicologica che va a costruire l’identità sociale di un individuo, costituita anche da una gerarchia di appartenenze multiple, all’interno delle quali è possibile distingure l’identità situata e l’identità transitoria, intese rispettivamente come identità stabile nel tempo e maggiormente saliente rispetto ad altre ad esempio il sesso, e come tipo di identità che può cambiare nel corso del tempo perché legata a particolari momenti vissuti o situazioni, come ad esempio l’ appartenenza politica;

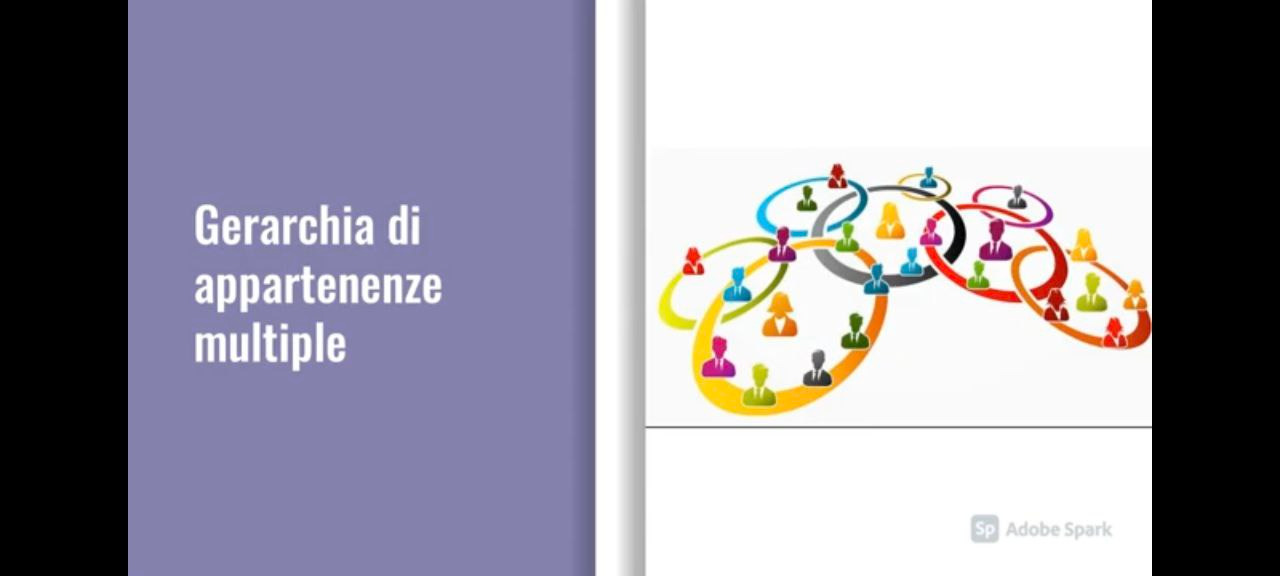
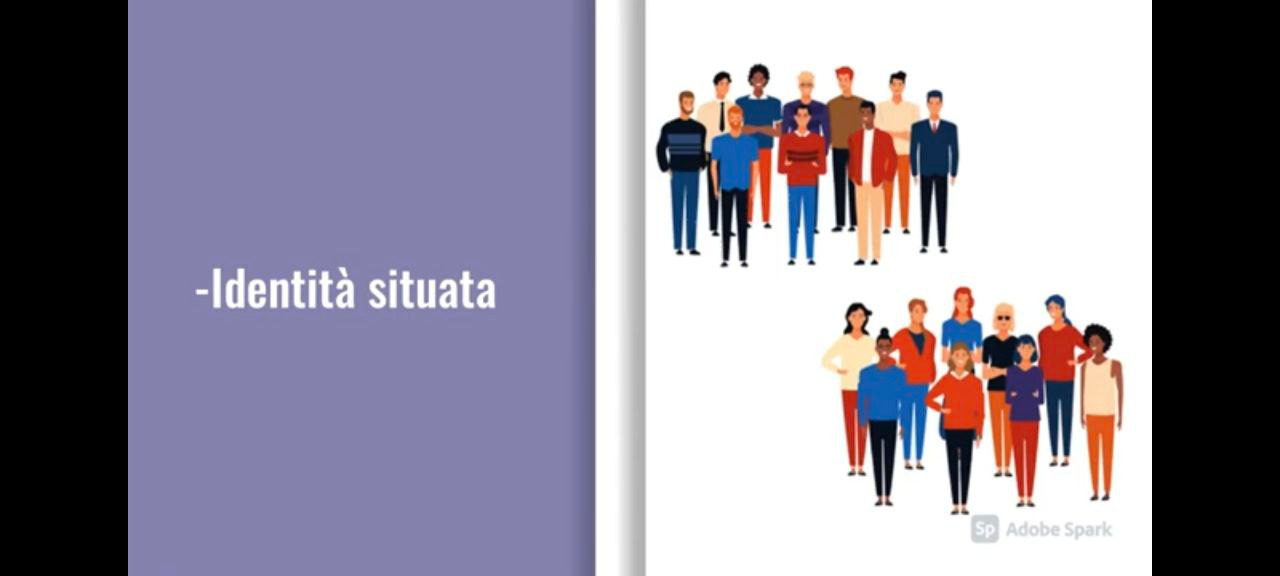

III processo: confronto sociale, secondo il quale, una volta determinata l’appartenenza ad un dato gruppo sociale, l’individuo tenderà ad effettuare sempre confronti tra gli appartenenti al gruppo interno con quello del gruppo esterno, riconoscendo il primo come il migliore, e considerato la tendenza dell’uomo a categorizzare ciò che lo circonda, ad attribuire un senso di ordine a tutela della sua appartenenza. Questo però può generare la formazione di una serie di pregiudizi nei confronti degli altri gruppi e questo comportamento è causato dai bias cognitivi di valutazione ovvero errori delle componenti mentali che conducono le rappresentazioni delle situazioni e dei rispettivi comportamenti. Questo spiega perché le persone tendono a preferire membri del proprio gruppo diffidando delle persone esterne ad esso.

Dall’identità sociale e alla modalità attraverso la quale l’individuo si sente parte di un sistema, possiamo analizzare gli aspetti della società nella loro connessione, così che ogni individuo possa sentirsi responsabile del buon andamento della società nel suo complesso fino alla visione opposta della società, intesa come luogo di lotte e conflitti, di divisione, antagonismo e ostilità.
Secondo la teoria del Funzionalismo strutturale, ogni aspetto della società è interdipendente e ciò contribuisce alla stabilità e al funzionamento della società nel suo complesso (Emile Durkheim). Pertanto, il funzionalismo evidenzia che è l'interdipendenza a tenere insieme le parti, tra queste varie funzioni o gli elementi della società stessa e a definire il mantenimento della società in un modo più efficace. In altre parole, l'approccio funzionalista sottolinea che il consenso sociale tiene insieme la società e l'accordo dei suoi membri, e quindi dovrebbero lavorare insieme per ottenere ciò che è meglio per la società nel suo insieme. Secondo il funzionalismo, l'interruzione di un aspetto ha un impatto complessivo sugli altri aspetti, influenzando infine l'equilibrio dell'intera società. Per superare questo, le persone dovrebbero adattarsi a nuovi modi. In altre parole, l'approccio funzionalista sottolinea che il consenso sociale tiene insieme la società e l'accordo dei suoi membri, e quindi dovrebbero lavorare insieme per ottenere ciò che è meglio per la società nel suo insieme.
L’altra faccia della medaglia, però, è rappresentata dalla teoria dei conflitti che mostra come la società sia in conflitto perpetuo di classe a causa della limitazione e della distribuzione ineguale delle risorse e come questa disuguaglianza tra le classi sociali alla fine generi il cambiamento sociale in una società. Di impronta Marxsista, la teoria del conflitto non attribuisce allo scontro, un’accezione negativa, al contrario, essa considera lo scontro come la fase embrionale di una successiva evoluzione.
Da questa tensione sociale, potremmo fare riferimento all’avvento di una nuova società, nella quale, considerati alcuni pilastri fondamentali, quali lo spirito identitario ed i processi che lo accompagnano, l’esigenza di sentirsi parte del tutto per determinare il buon andamento della società nel suo complesso, al problema delle diseguaglianze ed ai conflitti che da ciò si generano, nasce il concetto di modernità e postmodernità.

Concetto elaborato da Zygmunt Bauman quando ha paragonato la modernità e postmodernità rispettivamente allo stato solido e liquido della società. Mentre nell’era moderna tutto era considerato come una solida costruzione, allo stato attuale, invece ogni aspettto della vita può venire rimodellato artificialmente.
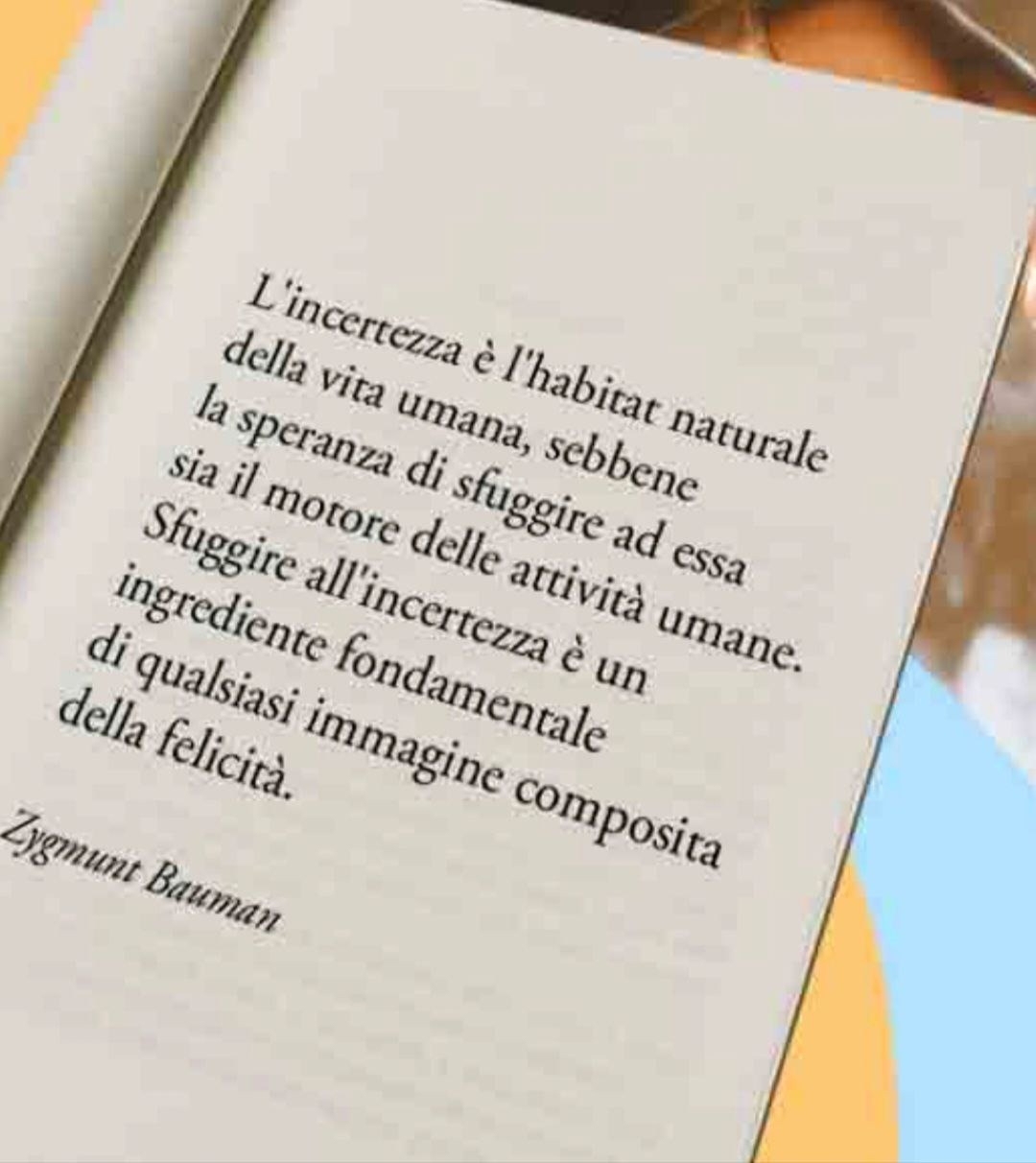
Ma cosa si intende esattamente per società liquida?
“Con la crisi del concetto di comunità emerge un individualismo sfrenato, dove nessuno è più compagno di strada ma antagonista di ciascuno, da cui guardarsi. Questo soggettivismo – così Umberto Eco spiegava Bauman - ha minato le basi della modernità, l’ha resa fragile, da qui una situazione in cui, mancando ogni punto di riferimento, tutto si dissolve in una sorta di liquidità”.
Si perde la certezza del diritto (la magistratura è sentita come nemica) e le uniche soluzioni per l’individuo senza punti di riferimento sono da un lato l’apparire a tutti costi, l’apparire come valore e il consumismo.
“Però si tratta di un consumismo che non mira al possesso di oggetti di desiderio in cui appagarsi, ma che li rende subito obsoleti, e il singolo passa da un consumo all’altro in una sorta di bulimia senza scopo”.
La modernità liquida, per dirla con le parole del sociologo polacco, è “la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza”.
Da qui discende una teoria del tutto personale, che ha faticato a trovare il suo posto nel nostro tempo, ma che oggi, memore dei vissuti idealistici e totalizzanti del passato, considera ciò che viene chiamata “società liquida”, la “società del cambiamento” con la sua forma flessibile in cui tutto si modella ed assume il contorno necessario per armonizzarsi nel mondo e con il mondo.